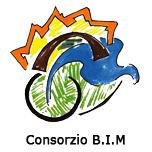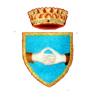L’orrore nel campo di prigionia di Meschede raccontato da Giuseppe Capoccetti
Nelle ultime pagine del diario di Giuseppe Capoccetti (1893 – 1978), artigliere originario di Cascia, rivive l’orrore del campo di prigionia di Meschede negli ultimi giorni della Grande Guerra:
…In questo frattempo la febbre spagnola imperversava e falciava inesorabilmente centinaia di vite umane. L’infermeria generale era piena di tubercolosi. I morti non si sotterravano perché il terreno era ricoperto di un grosso strato di ghiaccio, e allora li mettevano per otto accatastati dopo averli cosparsi con abbondante calce viva. Cose raccapriccianti al solo pensarci, ma purtroppo era così. Ormai si era più per la morte che per la vita.
Gli addetti all’infermeria dove ero io con Augusto Perazzini, alla mattina passavano per somministrare il cosiddetto caffè, e se toccavano i malati e questi non si muovevano, con la massima disinvoltura passavano oltre dicendo: “Anche questo è morto”. Più tardi passava un carrozzone a mano che li portava giù alla baracca trasformata in camera mortuaria, dove li mettevano accatastati come ho già detto, in attesa del disgelo – dicevano i tedeschi – ma noi eravamo più che convinti che li avrebbe attesi il rogo.
Era un continuo: anche io ebbi un grande raffreddore, e non mancandomi le aspirine ne presi due, poi tre la seconda sera, e fino a sei successivamente, Alfine ne parlai con un dottre Capitano, il quale spaventato mi proibì di prenderne ancora…».
Fonte: L’irto sentiero, ovvero le mie memorie di Giuseppe Capoccetti, Fuorilinea, 2014.